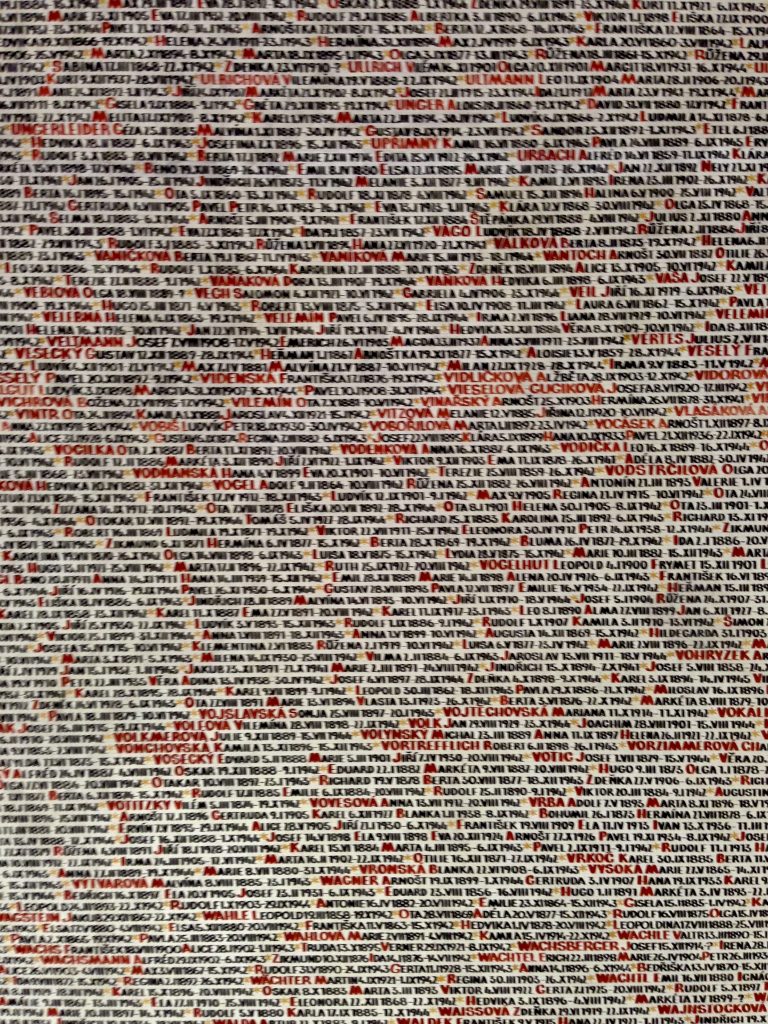KZ, il canto di quel poeta e musicista friulano che è Marco Maiero, ripete come un’ossessione “Ero, ero, ero… ero profumo di rosa, quercia sapiente e nodosa, ero padre, ero voce, ero sogni, ero sposa, profumo di rosa. Ero anima senza sorriso, senza pietà e paradiso, ero occhi e parole nel gelo, fame e deserto sul viso. Ora sono un ricordo, ora solo un ricordo scolpito nell’arida e incerta memoria della pietra del tempo”. KZ sta per “Konzentrationslager”, campo di concentramento, poi di sterminio.
“Stupisce che la terra che fra Sette e Ottocento ha dato i natali a Bach, Beethoven, Mozart, Kant, Hegel, vale a dire la summa della cultura europea, abbia partorito Himmler e tutti quei mostri che nel Novecento hanno straziato l’umanità”. Renzo Fracalossi, studioso di storia dell’ebraismo e della diaspora dei Figli d’Israele (suo il volume “La scuola dell’odio” sull’antisemitismo in Europa), lo afferma con lo sconcerto di chi ha visitato 38, i più noti ed efferati dei diecimila campi di concentramento e di smistamento allestiti dai nazisti negli anni della seconda guerra mondiale (1939-1945). Compresi i sette campi di esclusivo sterminio, insediati prevalentemente in Polonia e nei quali furono eliminati milioni di esseri umani. Colpevoli solo di essere uomini e donne, vecchi e bambini “diversi” dalla pura razza ariana (!): ebrei, zingari, omosessuali, malati di mente, handicappati.
Dei sette campi dell’odio elevato a sistema, dello scempio di massa, dell’annientamento di tutti coloro i quali non potevano servire da “schiavi di Hitler”, Auschwitz-Birkenau è il simbolo più immediato. Anche perché, il giorno in cui fu “liberato” dai soldati dell’Armata Rossa, il 27 gennaio 1945, è diventato l’anniversario “della memoria”. Una ricorrenza internazionale designata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 1° novembre 2005. Già cinque anni prima, il Parlamento italiano aveva riconosciuto con propria legge “il 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah (lo sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali (del 1938), la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. [… Tale ricorrenza, servirà per] conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico e oscuro periodo della storia del nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere” (artt. 1 e 2, legge n. 211, 20 luglio 2000).
Ogni anno, anche dalla provincia di Trento, centinaia di studenti delle scuole medie superiori raggiungono Auschwitz-Birkenau, per un “pellegrinaggio laico” dentro un frammento tragico della storia del XX secolo. Un treno lo organizza la Provincia (assessorato alle politiche giovanili), altri viaggi sono promossi dall’associazione “Terra del Fuoco”, di Torino, che dal 2005 ha già portato in visita ai due campi di sterminio circa 22mila giovani, tra 17 e 25 anni, di varie regioni d’Italia. Dal 2014 l’Associazione ha pure una “filiale” in Trentino. Dalla provincia di Trento, pandemia permettendo, andranno ad Auschwitz 178 giovani, dai 17 ai 25 anni. Il “treno della memoria”, quest’anno, partirà per la Polonia il 5 aprile per far ritorno a Trento il 10 aprile. Le iscrizioni sono aperte fino al 10 febbraio. I moduli di iscrizione si possono scaricare dai siti: www.arcideltrentino.it – www.deina.it
Personalmente, vi andammo nell’estate del 2016, dopo un’attesa di oltre sessant’anni. Con la curiosità del cronista, col timore di vedere, con la volontà di capire. Per cercare risposte a domande sospese tra l’incredulità e la vergogna.
Auschwitz, quindi. Duecento ettari di campo trasformati in cimitero-museo, 155 edifici, 300 strutture in rovina, centinaia di migliaia di reperti, effetti personali di oltre un milione di uomini e donne privati della loro umanità e sterminati senza pietà e dopo mille tormenti.
In questa landa fra le betulle, settanta chilometri da Cracovia, nella Polonia meridionale, bisognerebbe arrivare d’inverno. Quando la neve copre come un velo compassionevole la vergogna del mondo dei disumani. Quando le immagini, ormai tutte a colori, si imprimono nei micro-chip in bianco e nero. Quando il nero dà colore all’orrore e al disagio. Ma anche per chi arriva d’estate, il caldo infuocato si accompagna a docce gelate. I brividi corrono lungo la schiena, appena varcato il cancello di ferro dominato da quell’orrenda menzogna “Arbeit macht frei” (il lavoro rende liberi), il motto che fu collocato all’ingresso di numerosi campi di concentramento nazisti.
Un silenzio imbarazzato sovrasta il brusio di cento gruppi e di venti lingue diverse che attraversano i viali del campo, che entrano ed escono dai block, le costruzioni di mattoni rossi. Un silenzio stordito come il mancato cinguettio degli uccellini che pur dovrebbero essere annidati tra le fronde delle betulle. Neppure il frinire delle cicale fa da sottofondo alla torrida estate polacca.
Solo un assordante silenzio. I passi inseguono, con occhi bassi e pensosi, le impronte lasciate sulla ghiaia dei viali da altri passi. Dalla radio-cuffia arriva al cervello la voce della guida che alterna italiano ed inglese, che spiega, racconta, si indigna, rivela. Ciò che era, ciò che fu quello sterminato campo di sterminio.
Il fabbro polacco Jan Liwacz, oppositore politico non ebreo, che fu deportato ad Auschwitz il 20 giugno 1940, tatuato con il numero 1010, ebbe il compito di saldare la scritta all’ingresso del campo: “Arbeit mach frei”. Non gli restò che obbedire, ma per marcare la sua opposizione ai nazisti, rovesciò la lettera “B” di Arbeit. Così rimase e così è visibile oggi, recuperata e rispristinata dopo il furto che nel dicembre del 2009 fece scrivere di “profanazione” tutti i giornali del mondo. Nel 2014 toccò alla scritta beffarda sulla cancellata d’ingresso al lager di Dachau, vicino a Monaco di Baviera: “Jedem das Seine” (“A ciascuno il suo”). Il cancello è stato ritrovato in Norvegia il 2 dicembre 2016.
[“Jedem das Seine” è il titolo del recital che in queste settimane di gennaio-febbraio 2022, il regista e autore di teatro Renzo Fracalossi porta in varie località del Trentino quale stimolo a fare memoria dell’0locausto e delle barbarie inflitte ai milioni di esseri umani].
Sorto come campo di concentramento, nel lager di Auschwitz furono rinchiusi inizialmente prigionieri polacchi, internati per motivi politici. Auschwitz cambiò “ragione sociale” dopo la conferenza di Wansee a Berlino (20 gennaio 1942) nel corso della quale quindici funzionari del Partito Nazista e del Governo del Terzo Reich decretarono la “soluzione finale della questione ebraica”. Quella landa fra le betulle, a metà strada fra Cracovia e Katowice, fu trasformata nel più grande campo di sterminio della galassia nazista. A tre chilometri dal campo primitivo fu allestito Auschwitz II, Birkenau. Ed è l’immagine del binario d’ingresso (la Bahnrampe) sotto una torre di guardia a richiamare, quasi con ossessione, la Shoah, lo sterminio degli ebrei. Tutt’attorno, in un’area di quaranta chilometri quadrati, furono predisposti altri 45 sotto-campi.
Ad Auschwitz-Birkenau furono internati circa un milione e trecentomila esseri umani. Di questi, almeno un milione e centomila finirono nelle “docce”, le camere a gas rifornite da migliaia di barattoli di Zyklon B, l’acido cianidrico in grani che causava la morte dopo circa dieci minuti di sofferenze atroci.
Lo Zyklon B, inizialmente usato come antiparassitario, fu sperimentato per la prima volta come gas mortale il 3 settembre 1941, proprio ad Auschwitz, nei sotterranei del Block 11, quando furono uccisi 600 prigionieri di guerra sovietici e 250 deportati affetti da TBC.
Nei tre anni dello sterminio di massa, ad Auschwitz furono consumati 7.711 chili di Zyklon B. Per uccidere da mille a duemila esseri umani servivano da cinque a sette chili di veleno. Ma la morte, ad Auschwitz-Birkenau e negli altri campi di sterminio, fu praticata anche con la fucilazione, l’impiccagione, l’inedia, il freddo, le malattie, le epidemie, le iniezioni letali.
Sei forni crematori provvedevano, giorno e notte, a cancellare le tracce di quelle stragi nefande. La cenere era poi sparsa lungo i viali, per coprire il ghiaccio e la neve, per essere calpestata nell’ultimo tratto di vita da chi sarebbe diventato cenere e fumo, di lì a poco. Quando i forni diventarono insufficienti a bruciare le prove dell’immensa mattanza, quando lievitarono a dismisura i morti della denutrizione e delle epidemie causate dalle sperimentazioni dei medici-assassini alla Mengele, furono scavate dagli stessi deportati grandi fosse comuni. Lontane dai campi e, s’illudevano i nazisti, dal giudizio della storia.
Nel novembre del 1944, mentre le truppe Sovietiche dilagavano in Polonia, per raggiungere la Germania, il criminale nazista Heinrich Himmler, “Reichsführer der SS”, vale a dire “Guida delle SS del Reich”, diede ordine di cancellare le prove del genocidio. Le camere a gas e i crematori di Birkenau furono fatti saltare in aria con la dinamite. Le esecuzioni furono sospese. I prigionieri di Auschwitz furono avviati, a marce forzate, le Todesmärsche, verso la Germania.
Il 17 gennaio 1945, nei campi di Auschwitz-Birkenau e nei sotto-campi di Babitz, Budy e Plawny sopravvivevano 31.894 deportati. La marcia, a piedi, in pieno inverno polacco, vide lunghe colonne di donne e di bambini, seguite da un corteo ininterrotto di uomini. Morirono in quindicimila, uccisi dal gelo o da un colpo di pistola alla nuca, abbandonati ai bordi delle strade, lungo i sentieri nelle foreste verso la Slesia.
Ad Auschwitz e a Birkenau erano rimasti novemila esseri macilenti, sfiniti dalla fame e dalle angherie. Mentre saltavano i forni e le camere a gas, nella fretta di eliminare le prove dei loro massacri, i nazisti ritardarono l’eliminazione fisica di quelle larve umane. Circa 700 ebrei furono uccisi nei sottocampi prima dell’arrivo dei soldati dell’Armata Rossa, il 27 gennaio 1945.
Ad Auschwitz, oggi museo mondiale dell’olocausto (dal 1979 patrimonio dell’Umanità), molte strutture sono rimaste quelle di settant’anni fa.
Nei sotterranei del Block 11, c’è ancora la cella dove fu ucciso con un’iniezione di acido fenico il francescano polacco Massimiliano Kolbe, sopravvissuto per più di due settimane senza acqua né cibo. Massimiliano Kolbe, proclamato santo dalla Chiesa cattolica il 10 ottobre 1982, si era offerto di prendere il posto di un condannato a morte il quale aveva moglie due figli.
In quell’inferno buio e sotterraneo, le pareti annerite trasudano ancora lo strazio delle urla e delle bestemmie, l’eco delle orazioni e il lamento dei moribondi. Dalle fotografie che tappezzano le pareti di alcuni corridoi, gli occhi sbarrati dei deportati accompagnano le frotte di visitatori straniti. Nel Block 4, i capelli di 45mila donne assassinate (1.950 chili di capelli) fanno memoria dell’orrore e della barbarie. Erano venduti all’industria tessile tedesca per 50 pfennig al chilo che li trasformava in calze e calzettoni per i soldati del Terzo Reich.
Ai cadaveri, prima che fossero gettati tra le fiamme, strappavano i denti d’oro (una media di dieci chili al giorno). Poi toccava agli Sonderkommando, gli addetti ai forni e alle camere a gas. Erano prigionieri che poi avrebbero fatto la fine dei loro compagni di lager. Dal marzo 1943, nel Block 10, Karl Clauberg avviò esperimenti di sterilizzazione di massa, iniettando formalina nelle tube di Falloppio di migliaia di donne, destinate, dopo terribili sofferenze, alla camera a gas. Chi non sopportava l’attesa della morte, cercava la fine correndo verso il reticolato di filo spinato attraversato dalla corrente di 6mila volt.
Nell’altro campo, quello di Birkenau, è rimasto poco: solo l’odore della paura. Che aleggia, quasi un rigurgito della storia, fra distese di rovine e di campagna dove qua e là si levano pochi mattoni a far intuire una baracca o un forno crematorio.
Il vento, che per settant’anni ha cigolato fra queste lande della Polonia meridionale, s’è portato via l’odore di bruciato della carne e delle ossa di uomini e donne. Scarnificate dall’inedia e annientate in nome di quel dio della razza che i nazisti volevano “pura”.
Se l’abisso ha un nome non può che essere Auschwitz. Ebrei e cattolici si sono chiesti più volte “dov’era Dio” quando tutto questo accadeva. Se lo è chiesto persino il papa di Roma, Francesco, dopo che nel 2016 andò in visita a quel luogo di sterminio. E al teologo ebreo André Neher (1914-1988) che ha parlato del “silenzio di Dio”, fa da contrappunto l’osservazione di Primo Levi (1919-1987) il quale sosteneva che “se c’è Auschwitz non c’è Dio”. E se Dio c’è, si è smarrito anche lui dentro quella barbarie. Perché chi non ha visto l’abisso non può comprendere in pieno l’aberrazione di coloro i quali propugnavano la supremazia di una stirpe. Negando, allora come oggi, che c’è una sola razza: quella umana.
© 2022 Il Trentino Nuovo